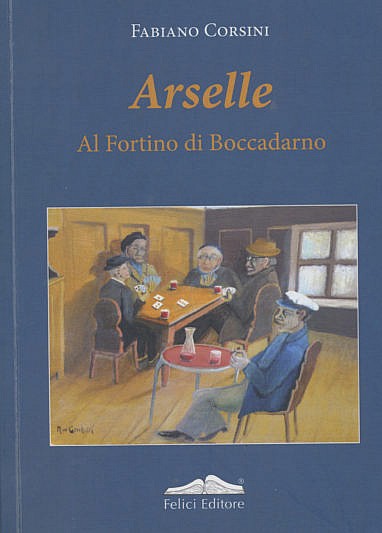 Il mare, il libeccio, il pesce, la fabbrica, gli attori che fanno il cinema a Tirrenia e che vengono a Marina a mangiare il “pasto di bordo”. La vita del dopoguerra, così come si svolgeva nelle case del Fortino, il quartiere brulicante di operai del Cantiere e di tanta gente che si ingegnava a conciliare il pranzo con la cena. Arselle, cicale, muggini, una cucina che ricorda le emozioni che si mischiano con gli odori della pineta e della vernice fresca che a primavera si preparava ad accogliere i villeggianti.
Il mare, il libeccio, il pesce, la fabbrica, gli attori che fanno il cinema a Tirrenia e che vengono a Marina a mangiare il “pasto di bordo”. La vita del dopoguerra, così come si svolgeva nelle case del Fortino, il quartiere brulicante di operai del Cantiere e di tanta gente che si ingegnava a conciliare il pranzo con la cena. Arselle, cicale, muggini, una cucina che ricorda le emozioni che si mischiano con gli odori della pineta e della vernice fresca che a primavera si preparava ad accogliere i villeggianti.
I licenziamenti del 1957 arrivano come un trauma che segna dolorosamente e per sempre quelle vite e questo paese. Il racconto è scandito dalla vicenda di Michele e della sua famiglia, con quella del Circolo “Il Fortino”, dove un tavolo occupato da imperturbabili giocatori di carte segna il tempo che passa.
Sullo sfondo, una Marina di Pisa struggente, ricordata con gli stessi accenti con i quali la descrisse nel 1952 Vittorio De Sica nel film “Stazione Termini”.
Prefazione
Questo libro è una manna dal cielo per chi, come il sottoscritto, è convinto che le storie minime delle persone comuni siano tanto degne quanto la storia con la “S” maiuscola, quella che si trova sui libri di scuola.
Storie minime che si possono ricondurre nell’alveo di ciò che mi piace chiamare “memoria locale”. Ed è esattamente quanto leggerete in queste pagine, pagine che trasudano passione per la propria comunità, per il proprio territorio, indugiando senza tanta nostalgia su un tempo che fu, che forse non ritornerà, ma che di sicuro ha tanto da insegnarci.
Da alcuni anni uso la metafora dei granai per la raccolta della memoria locale, i “granai della memoria”, su cui tutta l’associazione Slow Food ha deciso di impegnarsi insieme all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per raccogliere, registrare, immagazzinare quante più testimonianze possibile, piccole ma grandi storie come quelle contenute nelle pagine che seguono. Nei granai si ammassa il cibo per poter affrontare i tempi di carestia: noi dobbiamo cominciare a riempirli di queste memorie per poter affrontare le carestie culturali, future e (forse) presenti.
Non è un caso che un’associazione che si occupa di cibo e un’università di scienze gastronomiche siano le promotrici di questo progetto sulla memoria; come non è un caso che questo libro sia attraversato, sin dal titolo, dal cibo, dall’agricoltura, dalla pesca, dall’artigianato alimentare. Il cibo è sempre l’ossatura di una comunità, ciò che più la anima, ciò a cui tutto è connesso. Un tutto che quindi non si può raccontare senza parlare anche di cibo. Perché il cibo è socialità, è lavoro, è rito familiare e comunitario, è politica.
Questo libro è prezioso per i marines! che vi possono ritrovare la propria identità, le proprie radici, provare a leggerle ancora oggi nelle architetture che sono rimaste o in altri luoghi non troppo mutati da come sono raccontati o, ancora, cercando le persone che possono raccontare. Ma è prezioso per chiunque: traccia, a partire dagli uomini e dalle donne, e dal cibo, un affresco completo, in cui ci si può immergere con molto piacere attraverso la lettura, in cui ci si può riconoscere per il proprio passato se si ha una certa età, ma in cui un giovane può capire com’era l’Italia dei propri nonni e padri; perché c’è qualcosa di paradigmatico in questa storia.
La vicenda del Cantiere e del Fortino, i licenziamenti, lo stravolgimento di una comunità che, come molte altre a quel tempo, accanto alla fabbrica era ancora profondamente agricola. Il lavoro in fabbrica era qualcosa di necessario ma che si poteva svolgere senza abbandonare l’orto, i campi, la pesca, le attività secolari che scandivano i ritmi stagionali, i modi di nutrirsi, di socializzare, di fare economia locale. L’Italia è cambiata profondamente da allora, il boom economico ha portato un benessere immediato che però in cambio ha cancellato tanto, troppo del nostro territorio e dei nostri modi di fare comunità, qualcosa che abbiamo perso senza quasi rendercene conto, ma che può tornare in forme nuove e moderne. Attraverso il cibo, ma anche attraverso le lotte politiche che adesso si devono spostare inevitabilmente verso la tutela dei nostri territori, del nostro ambiente, del nostro mare, delle nostre campagne e dei nostri contadini.
A leggere di come si viveva negli anni ’50/’60, oggi sembra di vivere in un altro mondo, ma sono convinto che quel modo di rapportarsi tra le persone, quel modo di mangiare e condividere, quella passione politica, possano tutte ancora essere molto attuali. Senza doverle per forza ripetere nei dettagli, senza nessuna nostalgia (che non sarebbe né realistico né di buon senso), ma facendole nostre con un approccio diverso alle cose della vita, proprio per imparare di nuovo ad affrontare la realtà (che, va detto, non è una bellissima realtà).
Ecco, sono convinto che tutto questo non si possa fare senza memoria: dunque posso solo dire grazie per questo libro.
Carlo Petrini
Il Fortino e Fondomarina
In realtà Marina è divisa in due, praticamente da sempre. La parte nord, verso Boccadarno, è detta anche del Fortino, per la costruzione che secondo alcuni il Granduca dei Medici aveva edificato proprio lì già nei primi anni del 1600, e che comunque i Lorena, un secolo dopo, avevano trasformato in una vera e propria fortificazione, dentro il territorio di quello che sarà proprio il Cantiere. L’altra parte è per tutti Fondomarina, anche se chi vi abita ogni tanto stancamente si lamenta per una definizione che viene ritenuta scorretta. Ma così è.
E quasi incredibile quanto ancora oggi sia viva e profonda, nelle coscienze delle persone, questa sorta di separazione, che si rinfocola quando si parla di cose successe 40 o 50 anni fa. Chi stava dalle parti del Fortino in Fondomarina ci capitava di rado e malvolentieri. Piazza Gorgona, talvolta riempita per comizi e commemorazioni, era una specie di posto di frontiera; si doveva superarlo per arrivare in piazza Sardegna, in Fondomarina, dove c’erano la Scuola d’avviamento professionale e la Qualquonia, la scuola dei trovatelli. Ma si andava solo per lo stretto indispensabile. E quelli, anche i comunisti più schietti, che venivano da Fondomarina per arrivare a Villa Santa avevano un’immagine distante e abbastanza vaga di quello che accadeva dalle parti del Fortino.
Ai primi del Novecento il cuore pulsante del paese era la zona nord, quella del Fortino, dove il Cantiere era cresciuto, inglobando e abbattendo tutte le case dei Ceccherini, e poi lo stesso Fortino dei Medici. Non bastò, a fermarne la distruzione, nemmeno la lapide della cappella, che recava la data 1650.
Fino a che era rimasta la spiaggia, bagni e bagnetti erano cresciuti tra la Villa Peratoner, quasi alla Foce, la piazza della Rotonda e poi piazza Gorgona. Marina decadente e Marina proletaria per lunghi anni avevano convissuto in questa parte del paese. Poi le cose cambiarono, ma la divisione non diminuì. Anche la politica ha la sua geografia: negli anni ‘60 e ‘70 si vendevano centinaia di copie de “L’Unità” nella zona del Fortino; poche decine, invece, da Piazza Gorgona in là. E, dopo che il circolo di Villa Santa aveva chiuso, i fasti del Fortino non coinvolsero mai l’intera cittadina, non riuscirono a ripetere il successo paesano della prima casa del popolo del dopoguerra.
Il Fortino e la zona più vicina a Boccadarno persero un po’ alla volta la vocazione balneare per via dell’erosione della spiaggia, per la distruzione dei bagnetti, per la migrazione delle presenze nobili che animavano ville e alberghi. Il Bagno Emma, poi diventato Bagno la Foce, proprio a Boccadarno, quasi attaccato al Cantiere, si radicò un po’ alla volta come bagno popolare. Operai erano quelli che lo frequentavano, in un connubio inedito tra spiaggia e capannoni industriali. Con un humus nuovo, dove un po’ alla volta non trovarono più posto le fantasie liriche di Gabriele D’Annunzio, che pure aveva dimorato lì, ma dove germoglierà negli anni ‘60 la fantasia gastronomica di Gino, il cuoco che preparava i pasti per la mensa operaia e poi mise su la sua trattoria.
Alle elementari Michele andò, come tutti, alla Scuola Newbery. Ma-quando, a 10 anni, cominciò con la scuola media, era il 1959, doveva arrivare ogni giorno in via Cagliaritana, in Fondomarina. Finché non misero il pullman, la camminata dalla via della Foce era una camminata tanto lunga, quanto avventurosa. Perché dopo la rotonda di piazza Baleari c’era da affrontare un percorso che per un bambino poteva essere preoccupante. A partire dal Gonnelli, l’emporio-bottega a metà di via Moriconi, sul vecchio tracciato del trenino, si procedeva verso Fondomarina con un percorso a tratti non asfaltato. Si passava poi in una zona quasi sempre coperta d’acqua, acqua di pioggia mischiata ad acqua salata arrivata con le mareggiate. Un Paduletto, come appunto si chiamava. Con cani che circolavano liberi a branchi e l’inquietante presenza di squadre popolatissime di ragazzi dai sei ai venti anni, che se eri del Fortino potevano anche rincorrerti e prenderti a cazzotti. Specialmente se tra loro c’era Eliseo, qualcuno dei fratelli Serassani, o il Della Sora. Roba da far impallidire i ragazzi della via Pai. Del resto, continuò per qualche decennio la tradizione delle efferate battaglie lungo i binari del trammino, in pineta. Quelli di Fondomarina e quelli del Fortino, una volta all’anno, in genere alla fine dell’estate, si affrontavano con bastoni, strombole, fucilini a coccole o anche qualcosa di più. Nessuno si era mai fatto né si fece mai veramente male, ma le battaglie mettevano paura. Qualche volta dovette fermarsi anche il trammino, per le pietre messe sui binari da qualcuno più agitato degli altri.
Oltre piazza Sardegna non si andava davvero mai. Fino agli anni della guerra dopo la via d’Amino cominciava una boscaglia fittissima, una foresta, come il nome dello stabilimento che segnava la fine dei bagni marinesi. Dietro l’ospizio di Padre Agostino c’era un’altra depressione, con un altro grande paduletto rimasto selvaggio. Il regista Alberto Lattuada scelse questo posto, nel 1948, per girare il film Senza Pietà, che raccontava di un amore tragico tra una “signorina” e un militare americano. Una di quelle che a Tombolo “andavano con i negri”, come ce n’erano state anche a Marina. La gente se lo ricordava, ma nessuno ne fece mai una questione.
La lavorazione del film fu l’occasione per tutti di andare in Fondomarina a spiare Carla < el Poggio, l’attrice protagonista. Truccata col cerone sembrava una bambola bellissima. Tutti si inventavano di averla vista bene in viso, e qualcuno di averle anche detto qualcosa. Le sequenze finali del film ci mostrano un lungomare desolato, dalla Chiesa di Padre Agostino fino alla piazza Sardegna: la strada sconnessa, le facciate scalcinate, lo scheletro di un retone, dove non c’era più sabbia. Finito il film, il Paduletto tornò al suo desolante abbandono e in Fondomarina quelli del Fortino ripresero a non andare.
Anche dalle parti del Fortino, a Boccadarno, le presenze erano piuttosto selvatiche. Quando arrivarono Fernanda e Felice c’era già un insediamento di operai, abbastanza recente e poco radicato, fatto di persone che cominciavano a sentirsi accomunate. Gli operai erano e si consideravano un po’ privilegiati. Privilegiati, rispetto al brulicare di attività improvvisate e precarie, legate al mare, al bosco, ai traffici di un lungo dopoguerra fatto di insediamenti americani, di smantellamenti di strutture e attrezzature, di ferrovie dismesse e di metalli da riciclare, e perché no, di prostituzione, ricettazione, attività collegate al porto di Livorno e a Tombolo. C’erano gli operai del Cantiere e accanto a loro una società fatta di immigrati recenti, venuti da ogni dove, gente che la guerra aveva fatto spostare dalle loro terre e dalle loro attività. Aspiravano di lavorare al Cantiere, o semplicemente si ingegnavano per raccogliere qualcosa di quella ricchezza che cominciava a circolare. C’erano i pescatori veri, quelli che uscivano con le barche, e quelli che vivevano di pesca sull’Arno, grazie alle anguille, ai muggini, alle cee, ai muscoli e alle arselle. Le arselle erano per i poveri una grande ricchezza, perché bastava un rastrello, che molti sapevano costruire da sé, e trainandolo sulla rena si poteva tirarne su qualche prezioso chilo. Da vendere o da mangiare.
Poi c’erano quelli che sull’Arno si tuffavano e si immergevano, per recuperare ferri e attrezzi. I fondali davanti alla foce alla fine della guerra erano diventati una grande discarica di macchinari del Cantiere, gettati in mare dagli americani. C’erano metalli, attrezzature e strumentazioni che ci si ingegnava a rimettere in funzione.
Il ferro si raccoglieva anche alla ferrovia dismessa, lungo i binari che la collegavano al Cantiere. Ai rifugi antiaerei di cemento armato e nei ruderi delle recinzioni del campo. Quando gli adulti smisero di dedicarsi a queste attività, perché ormai avevano trovato altri lavori, continuarono i ragazzi e poi i bambini. Un chilo di ferro quindici lire, pari al costo di una bibita o di un gelato; o anche di una Stop Lunga con Litro, la magica sigaretta che potevano comprare senza troppi problemi anche i ragazzetti.
Eravamo all’inizio degli anni ‘50, ancora vicini alla guerra. Il Fortino allora brulicava di famiglie, alle prese con una miseria non più nera ma certo opprimente. La maggior parte si dichiarava comunista; perché comunismo coincideva con una pur vaga promessa di miglioramento e di identità sociale. Erano per lo più persone che lavoravano da mattina e sera, si arrangiavano in qualche modo. E si dicevano disoccupate, se non lavoravano al Cantiere.
I luoghi: Fortino e Marina
Stazione Termini fu girato nel 1952 e racconta di un incontro tra due persone che si innamorano, sapendo che il loro sarà un amore impossibile. Alla stazione, in attesa di un treno che li dividerà per sempre, lasciandoli con la nostalgia di una storia che non c’è stata, si svolge la scena madre del film. Montgomery Clift aveva uno sguardo particolare, uno sguardo sognante che faceva sognare le donne, milioni di donne che spasimavano per lui. Ed è sicuramente per questo che Vittorio De Sica lo scelse.
Quando, nel film, si trattò di dare al sogno una dimensione ancora più intensa, di trasformarlo in una specie di poesia della nostalgia e dell’irrimediabilmente perduto, De Sica fece parlare Clift di un paese straordinario, dove la gente viveva felice senza grandi ricchezze. Dove si prendeva l’acqua dal pozzo, ci si faceva aiutare dagli asini. Dove si sentiva l’uggia del vento di libeccio, e quando si scatenava la pioggia andava via la corrente. Il luogo da sogno evocato nel film è Marina di Pisa.
Montgomery Clift: “Maria Maria Maria, mi figuravo tutto così diverso… Mi hanno offerto quel posto all’Università di Pisa, dove insegnava mio padre. Speravo che tu ed io potessimo vivere a Marina di Pisa, nella casa dove sono nato. Ti piacerebbe quella casa vicino al mare. Io insegnerei a Catia a remare…”.
Jennifer Jones: “Però dovresti insegnarle prima a nuotare”.
“E poi potrei comprarle anche un asino”.
“Un asino? Cosa se ne farebbe una bambina così di un grosso asi- no? “Ma non dico mica un asino molto grande… No basterebbe… Un asino è molto forte, potremmo attaccarlo ad una carrozzina, le farebbe piacere. Non posso dirti bugie. Lì non è un paradiso. Non sono un uomo ricco. Per esempio l’acqua la prendiamo dal pozzo e ogni volta che c’è un temporale l’elettricità se ne va”.
“E bella la luce delle candele”.
“Quando soffia il vento dall’Africa fa molto caldo, dà sui nervi, e tutti litigano. Io e te è probabile che si litighi molto”.
“Noi due caro? E perché?”.
“Eh bè, perché anche mio padre e mia madre litigavano”.
“Credevo che fossero stati felici”.
“Lo erano, molto, solo che lui era italiano, agiva all’italiana, voleva vivere a modo suo: uscire da solo la sera, andare al caffè e giocare a carte. Mia madre voleva che lui restasse a casa…”.
“Ma anche io., cioè, certo non mi piacerebbe che tu uscissi tutte le sere lasciandomi sola…”.
“A rammendare le calze o cucinare per me… non ti piacerebbe? A me si! Non dimenticare che sono italiano e se non ti portassi bene… Ti picchierei”.
“Giovanni non lo faresti… O lo faresti?”.
“Certo, naturalmente, ma non ti preoccupare non andrò a giocare a carte, almeno stanotte. Andiamo a casa mia, accendiamo un fuoco e staremo tranquilli. Potremo pensare a come avrebbe potuto essere”.
A come avrebbe potuto essere se si fossero incontrati prima. Se avessero potuto vivere in un luogo incantevole come Marina di Pisa. Chi ha scritto questo dialogo deve aver vissuto da queste parti. Deve aver provato l’emozione del vento che fa diventare tutti nervosi, e condiviso l’esperienza della luce che se ne va quando ci sono i temporali. Accadeva alla fine degli anni ‘40, come narra il film, accade oggi. È forse Vittorio De Sica, che conosceva questo paese, perché agli stabilimenti di Tirrenia aveva lavorato molte volte. I dialoghi sono probabilmente di Luigi Chiarini, uno dei due sceneggiatori, che fu docente all’Università di Pisa. La scena comunque raggiunge il suo obiettivo.
Il vento, il pozzo, l’asino, il bar dove gli uomini vanno, da soli, a giocare a carte. Sono gli stessi tratti con cui si apre il racconto dell’arrivo a Marina di Felice e Fernanda. Ma non c’è la ricerca del pittoresco, non è una cartolina di maniera. Non lo è nel film di De Sica, non lo è nel racconto di “Arselle”, che cerca di narrare la Marina di Pisa come veramente era, prima che fosse toccata dalle ruspe della modernità. E l’incanto di Boccadarno, che fa il suo giro.
Fabiano Corsini
Laureato in Sociologia presso l’Università di Trento nel 1973. Dirigente Slow Food Pisa e referente regionale Slow Food Salviamo il Paesaggio. Coordinatore dell’Associazione “salviamo il paesaggio del litorale pisano” e segretario del “Gruppo di San Rossore onlus”. Autore del libro (narrativa) “Arselle”, con la prefazione di Carlo Petrini, Pisa 2012. Dirige il sito “www.unaltravoce.it” e il portale www.reform.it. Ha ideato e dirige “Marina slow”, manifestazione dedicata a pesce e comunità.
a cura di massimocec dicembre 2018
